CARATTERISTICHE EDITORIALI E FISICHE
La prima uscita della nuovissima collana de I Romanzi di Urania (in contrapposizione a Urania Rivista, qui la recensione del primo numero) appare in edicola nel mese di ottobre 1952 e contiene un romanzo di appena un anno prima. L'Italia era entrata da pochi anni in un dopoguerra pieno di ottimismo e finalmente arrivava sulle nostre sponde una bella fetta di quella letteratura anglosassone che il regime fascista non ci teneva particolarmente a far pubblicare.
Arthur C. Clarke, già famoso all'estero per la sua narrativa breve attenta agli aspetti scientifici, fu scelto per aprire la serie.
The Sands of Mars è il suo terzo romanzo, quello che lo consacra definitivamente come pioniere della hard science fiction, quel sottogenere della fantascienza attento alla plausibilità in cui l'accuratezza scientifica non solo è importante ma spesso anche il motore della storia. Esce per la prima volta nel 1951 in UK per i tipi di Sidgwick&Jackson e ha da subito un notevole successo, tant'è che nel giro di quattro anni avrà già 11 versioni estere inclusa questa e quella giapponese.
Il numero che ho la fortuna e il privilegio di avere a scaffale è la seconda traduzione dell'opera in assoluto (preceduta da quella tedesca) e la terza edizione estera (preceduta solo da quella americana), il che rivela qualcosa della lungimiranza di Giorgio Monicelli, curatore della testata, nello scegliere cosa pubblicare.
Il volume è in condizioni strepitose. Presenta un ex libris con stemma araldico della famiglia Barea Toscan, come il numero 2 in mio possesso, anche in questo caso senza dati posizionali e, parimenti, lo stato di conservazione è incredibile. Colori brillanti, rilegatura squadrata, angoli in buone condizioni, pagine ragionevolmente bianche, costina dritta e pulita.
Ai più non dirà molto, ma ai vecchi collezionisti rivelo che si tratta di uno UOR2 - cioè una specifica versione del primo numero di Urania, di cui esistono diverse stampe contemporanee. Si ipotizza fosse perché Mondadori si era servita di piccoli stampatori con un controllo qualità non proprio eccellente. Non starò a dilungarmi sulle differenze tra le varie versioni, ci ha già pensato l'illustrissimo Custode, ma riguardano il tipo di font dei numeri di pagina, la suddivisione in sedicesimi, l'uso di fili da legatoria o meno e altri indizi tipografici.
Parlo subito dell'elefante nella stanza: c'è un clamoroso errore di battitura sulla costina. "Clarke" diventa "Clark" nonostante la copertina riporti il cognome corretto! Questo però è normale: non sono in possesso di una rarissima copia "fallata", sono proprio tutte così e il difetto è persino stato riprodotto nella copia anastatica che Mondadori pubblicò nel 1982 per celebrare il trentennale della collana.
La traduzione è della bravissima Maria Gallone, di cui non riesco a reperire informazioni biografiche: so solo che ha tradotto autori di spessore nel campo della fantascienza, del fantastico e del giallo (Arthur Conan Doyle, tra gli altri). La signora meriterebbe una voce sull'enciclopedia perché sapeva fare molto bene il suo lavoro: la incontreremo ancora nel corso della serie. Il suo lavoro su Le sabbie di Marte è avventuroso ma non dilettantesco, anzi. Certo, si trovano curiose locuzioni come "congegno di propulsione potentemente radioattivato", ma sono di norma tentativi ragionati di traslare in italiano concetti decisamente nuovi. La traduzione è permeata di termini per noi desueti e fioriti, come l'uso di "dottrina" per dire "conoscenza" o "progettatori" per "progettisti", ma non è un problema perché sentir chiamare "romanzetti" le relazioni sentimentali e vedere il rumore di fondo della radio descritto come un "tumultuante sobbollimento d'interferenze cosmiche" vale dieci volte il prezzo del biglietto!
I refusi abbondano, nella "miglior" tradizione uraniana chiamata "Revisione di bozze? NO GRAZIE!": Encelado diventa "Encladus", ad esempio, lasciandomi sospettare che la Gallone non abbia trovato il nome italiano di quella specifica luna di Saturno e si sia chiaramente dimenticata una "e" nel trascrivere l'originale in inglese. Ne ho contati una dozzina, poi ho smesso. Questo all'inizio era normale perché Monicelli, in realtà, non aveva una vera e propria redazione e nemmeno un ufficio: la redazione era casa sua, era lì che avveniva la maggior parte del lavoro e non c'erano collaboratori residenti. Si faceva tutto per posta, per telefono o durante riunioni casalinghe. Dalla sua scrivania passavano le traduzioni e le illustrazioni, unico aiuto sua moglie Maria Teresa Maglione, valente autrice e traduttrice anche lei. Solo qualche anno dopo sarebbe arrivata la mitica Andreina Negretti - a cui dobbiamo, ahimè, i rilevanti tagli per cui Urania fu sempre famigerata almeno fino alla gestione Fruttero & Lucentini inclusa. Può sembrare strano che un editore tanto importante apra una testata con così scarsi investimenti, ma al tempo Urania era una scommessa audace ed è ragionevole che Mondadori non intendesse rischiarci troppo. Prova ne sia il fallimento di Urania Rivista dopo soli 14 numeri.
Terminate queste note storiche - e ci sarebbe ancora molto da dire - arrivo alla recensione, ma prima permettetemi una piccola confessione: aprire questo libro per la prima volta mi ha emozionato.
Ho sentito il tuffo al cuore di Indiana Jones davanti all'Arca dell'Alleanza: questo è l'inizio della storia della fantascienza in Italia come letteratura di massa. Comincia tutto qui. C'erano stati alcuni esperimenti semi-amatoriali condotti da editori più piccoli, ma erano tutti morti nel giro di pochi numeri. Nei primi cento Urania, invece, dietro cui c'erano la Mondadori e un curatore competente, nasce molto del lessico fantascientifico in uso ancora oggi grazie a traduttori avventurosi costretti a improvvisare tra neologismi mai sentiti e concetti astrusi difficili da capire, figuriamoci da rendere, e si definiscono anche, numero dopo numero, gli stilemi dell'illustrazione di genere nel nostro Paese grazie a Caesar, Iacono, BELT e gli altri (curiosamente questo volume non contiene illustrazioni, però, che fanno la loro comparsa a partire dal numero 3).
Per capire quanto pionieristica sia stata questa collana basti pensare che, nella scheda dell'opera redatta da Monicelli, troviamo il primo uso attestato del termine fantascienza - anzi, "fanta-scienza", come si vede in foto qui sotto, ma d'altronde era una parola appena inventata!
Sarà un onore fare con voi questo viaggio, spero vi entusiasmi almeno la metà di quanto elettrizza me.
RECENSIONE (SPOILER!)
Fin dalle prime righe facciamo la conoscenza di Martin Gibson, giornalista e autore di "fanta-scienza" nonché palese self insert di Clarke nel libro, impegnato in conversazione col pilota del razzo a propellente chimico che lo porterà a 2000 chilometri di quota - alla prima stazione spaziale in orbita terrestre sia per anzianità che per distanza. Va su Marte per scrivere le sue impressioni di un mondo in via di colonizzazione e venderle ai giornali.
Clarke, esibendo la caratteristica principale della sua cifra stilistica, si butta subito a capofitto in accurate descrizioni tecniche che elicitano il sense of wonder del lettore il quale, nel 1951, non aveva altro modo di farsi un'idea di come potesse essere trovarsi nello spazio: quando è uscito questo romanzo niente aveva ancora oltrepassato l'atmosfera. Il primo satellite, lo Sputnik, andò in orbita solo nel 1957. Quando Gibson, all'inizio del libro, arriva alla stazione da cui partirà per Marte, la sue esperienza di trovarsi all'interno di una ciambella rotante è descritta con dovizia di particolari e spiegazioni, regalando un senso di immersione affascinante e totale. Clarke descrive ogni cosa scendendo nel dettaglio senza annoiare ed è impressionante vedere come la sua immaginazione assomigli alla realtà fisica, che oggi conosciamo bene, della permanenza e del viaggio nello spazio. L'intero romanzo è così. Attraverso il punto di vista di Gibson viviamo con lui lo sconcerto di vedere persone che lavorano su tutte le pareti della Ares, la nave che lo porterà su Marte nel suo viaggio inaugurale, dato che si trovano in microgravità. La forma stessa della nave appare assurda, non assomiglia affatto a un razzo cromato inutilmente aerodinamico come nei fumetti. Dato che non entra mai in atmosfera la Ares è costituita da due sezioni sferiche, una per l'equipaggio e una per motori e carburante atomico, collegate da un tubo a creare una forma simile a un manubrio da pesistica. Clarke descrive correttamente persino una fionda gravitazionale intorno alla Terra che serve alla nave per raggiungere in economia la velocità necessaria per il viaggio. Oggi queste cose possono sembrarci relativamente ovvie (e comunque moltissimi registi ancora non ci sono arrivati, troppe sono le astronavi simili ad aerei) ma al tempo era inconcepibile avere in qualche romanzo descrizioni così realistiche, basate nella fisica.
La prima parte del romanzo, circa un terzo, è dedicata alla descrizione del viaggio sotto ogni aspetto, soprattutto i più tecnici, e contiene una deliziosa discussione molto metatestuale tra Gibson e un membro dell'equipaggio riguardo all'annosa questione "la fantascienza è vera letteratura? Che valore ha se viene superata dalle conoscenze scientifiche?", che al tempo era ancora controversa. Veniamo quindi introdotti al funzionamento della Ares, degli "scafandri spaziali", cilindri rigidi con propulsori e braccia articolate comandabili dall'interno, nonché un cavo di sicurezza agganciato alla nave durante le attività extraveicolari - esattamente come gli astronauti odierni, nonché delle varie attività di bordo, fino all'arrivo su Marte. O, più precisamente, su Deimos, da cui Gibson prende un razzo per la superficie e ci vengono deliziosamente descritti l'entrata in atmosfera, la frizione per dissipare accelerazione e il plasma che avvolge il razzo... tutto questo 6 anni prima del primo satellite. Una volta ammartati scopriamo che stanno costruendo una cupola climatizzata di trecento metri di diametro per espandere il già "esacupolato" insediamento di Porto Lowell, nell'omonimo cratere.
Come si è ormai compreso qui, dal punto di vista della plausibilità, siamo nell'empireo. Basti pensare che Clarke, ben prima che ne esistesse uno, fu il primo a descrivere compiutamente un satellite geostazionario e la relativa meccanica orbitale. L'accuratezza scientifica è parte integrante della storia, motore dell'azione, generatrice di sense of wonder. Clarke è maestro nel fare ciò che, secondo me, dovrebbe fare ogni buon romanzo di fantascienza: estrapolare in maniera credibile rimanendo con i piedi ben piantati a terra, a partire dalle conoscenze del momento in cui si scrive, senza particolari concessioni alla "fanta" e con grande rispetto della scienza. Basti portare ad esempio il fatto che, in microgravità, tutti bevono succhiando da contenitori a bulbo, idea per il tempo assolutamente rivoluzionaria, e che si dorme assicurati alle brande con fasce elastiche. Ci sono delle eccezioni (a bordo della Ares tutti fumano, ad esempio), ma Clarke riesce a rendere plausibile persino il cambiamento societario conseguente all'avanzamento tecnologico: in questo mondo gli universitari al secondo anno, come "lavoretto estivo", si imbarcano sui razzi che fanno la spola Terra-Luna, così imparano pure il mestiere. O ancora, c'è polemica sulla Terra riguardo ai "soldi buttati su Marte" per la creazione di una nuova società, che appare inutile all'opinione pubblica e anticipa di 10 anni le analoghe obiezioni che saranno sollevate verso le prime missioni Gemini e Apollo.
Ciò non vuole dire che non vi siano difetti sotto questo aspetto, dovuti di norma alle scarse o errate conoscenze che avevamo in quel periodo. Per dirne qualcuna:
- su Marte si indossano comunissimi vestiti di stoffa e basta una maschera a ossigeno per farsi una passeggiata all'esterno;
- si può benissimo parlare senza radio;
- ci sono piante autoctone e vi crescono fiori terrestri;
- Fobos (Phobos nel testo, come in originale) e Deimos, la cui forma è indistinguibile dalla Terra, sono perfettamente sferici.
È difficile fare un riassunto della trama: non succede quasi niente. L'elemento umano è quasi assente, come è comune nella hard sf, e tutto si gioca nel condurre il lettore per mano su un mondo alieno in via di colonizzazione per "fargli vedere il paesaggio", per così dire. Si resta affascinati dal modo in cui i coloni marziani di Porto Lowell estraggono ossigeno dalla sabbia ossidata per rendere l'atmosfera sotto le cupole più simile a quella terrestre e rimuovono l'anidride carbonica grazie a piante terrestri importate (che crescono fino a dimensioni colossali a causa della bassa gravità). La carne si produce in laboratorio, le colture sono idroponiche. Non c'è aspetto della colonizzazione marziana che Clarke non si sia sforzato di rendere realistico fin nei dettagli più minuti.
Anche gli accidenti che capitano a Gibson nel corso della sua permanenza sono solo una scusa per sfoggiare la scienza. Nel corso di uno di essi un personaggio descrive Saturno e il suo sistema di lune e anelli in modo incredibilmente realistico, poi ci sono alcune argute invenzioni relative a fauna e flora marziane... e non dico altro, perché sarebbe un peccato rovinare l'unico, singolo "colpo di scena" del libro. Le virgolette sono lì perché non arriva come una sorpresa, si capisce da 100 pagine prima, ma il punto, con Clarke, non è quello: è farci restare a bocca aperta con le meraviglie del possibile, pervasi da un ottimismo per il futuro che troppo spesso manca nella fantascienza degli ultimi anni.
Il numero si chiude con la prima puntata del romanzo Oltre l'invisibile di Clifford D. Simak, una rubrica scientifica in cui si parla di comete con adeguata proprietà (l'unica cosa che proprio non sapevamo era la loro genesi) e una sezione enigmistica.
 |
| La prima, fantastica copertina di Curt Caesar per Urania: inizio col botto! |
 |
| Non fanno più i libroni divulgativi di prestigio di una volta |
| L'impeccabile costina col terribile errore di battitura: chi mal comincia... a quanto pare poi ha una vita editoriale di oltre 70 anni. Sorprendente! |
 | |
|
 |
| Frontespizio con ex libris |
 |
| La scheda del romanzo, opera di Monicelli, con la prima attestazione del termine "fantascienza" |
 |
| Si comincia! |
 | |
|
 |
| Pubblicità di Urania Rivista: 160 pagine per 150 lire erano un affarone |
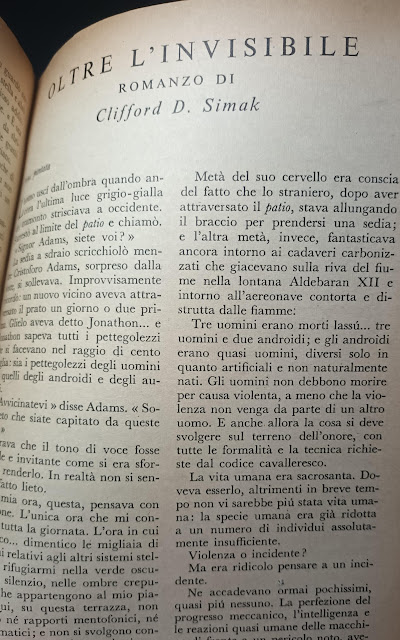 |
| Il romanzo a puntate di Simak |
 |
| "Il fatto incredibile" è la versione vintage di "me l'ha detto mio cuggino" |
 | |
|
 | |
|
 | |
|
 |
| Il piano dell'opera include romanzetti da niente, proprio |
 |
| Ultima pubblicità interna, giustamente dei Gialli che al tempo erano una delle testate di punta della casa editrice |

Pregevole quando si prende in giro a solo con queste parole: "Questo è il guaio di tutte le vecchie favole del buon tempo andato… non c’è niente che sia più morto dei racconti avveniristici di ieri"! ;-)
RispondiEliminaMolto meta!
Elimina